
Valentina Tamborra a Milano
Valentina Tamborra presenta, in anteprima assoluta, il suo ultimo libro, “Incontri al confine”, alla Libreria Verso di Milano. Appuntamento alle ore 19.00 in Corso di Porta Ticinese, 40. Dialoga con

Qualche mese fa, abbiamo fermato degli sconosciuti per chiedergli cosa fosse la marginalità. All’inizio, abbiamo raccolto facce perplesse e sguardi imbarazzati. Poi, timidamente, sono sbocciate le prime risposte: è un confine che segna cosa è dentro e cosa è fuori. È un diverso punto di vista. Risposte che crescevano, si aprivano e si intrecciavano. Qualcosa che è stato accantonato, e non per forza giustamente. Oggi mi trovo di fronte a una pagina bianca, braccia incrociate, a pormi la stessa domanda. Cosa intravedo io nei margini? Prima di tutto, l’erbaccia. Le sterpaglie, i rovi, le piante infestanti. Le vedo crescere ai bordi delle autostrade, sotto i guardrail, ai lati delle strade ferrate delle ferrovie del sud. Le vedo tra i palazzi, dietro le pompe di benzina, negli anfratti tra i sampietrini dei marciapiedi. Le vedo tra i vuoti della maglia della città. Le vedo in spazi liminali, abbandonati, improduttivi, invisibili.
Gilles Clément, architetto paesaggista, lo chiama Terzo Paesaggio. Ogni singolo ciuffo d’erba non amministrato, ogni vita che nasce oltre il confine. Il confine tra la città e il residuo, l’utile e l’inutile, l’ordine e il disordine. Oltre il confine, ciò che conta è solo l’assenza. Quella dell’uomo, quella dei giardinieri, il loro ordine e la loro disciplina. Eppure, Clément afferma che in quell’assenza c’è vita. Tra questi frammenti di paesaggio, nessuna somiglianza di forma. Un solo punto in comune: essere territori di rifugio per la diversità. Terre di frontiera, luoghi di ibridazione (motore dell’evoluzione biologica) dove le specie si mescolano, strabordano, gli insetti confondono pollini e le piante pioniere colonizzano anfratti dove la vita sembrerebbe impossibile. Invece, nei pratini curati delle villette, così apparentemente desiderabili e perfetti, c’è violenza.
La violenza dell’omologazione, dell’estirpazione di ogni piantina differente pur di avere fili d’erba tutti identici a se stessi, alti uguali, verdi uguali, fatti col timbro clone di Photoshop. Delle volte è una violenza che soffoca dolcemente, come i genitori preoccupati di un bimbo che a carnevale vuole vestirsi da Elsa e a Natale chiede Barbie Sirena. Come l’amichetta delle elementari che ti dice che saresti bella se ti aggiustassi un po’, come chi ti fa il piatto più piccolo perché sei donna o sei grassa, come tuo padre a cui sono sempre piaciuti i tuoi disegni ma oggi ti prende in disparte e ti consiglia di imparare un mestiere vero.
Altre volte, è una violenza brutale e lampante. È il ginocchio di un poliziotto che preme contro il collo di un afroamericano, è l’odio di un secondino, è la morte in mare e le frustate ai confini, è il tuo professore che ti dice di andare a fare l’estetista, è una scuola senza rampe, una panchina dove non ti puoi stendere, l’unico ginecologo del tuo paese che si rifiuta di farti abortire. Sono gli applausi scroscianti in Parlamento dopo aver affondato una legge che prometteva di tutelarti, sono i pugni in faccia per cancellare la tua natura, a dirti che margine sei e margine resterai.
Forse. Perché, nonostante sia confinato in piccoli spazi isolati e lontani da dove si prendono le decisioni, il margine non resta lì a soccombere, arido e morto. È vivo, pieno di storie, nuovi immaginari, identità, ribellioni, interconnessioni e alleanze. Nell’incolto (friche) e nel residuo (délaissé), la diversità ha spazio per crescere, non assoggettata e soffocata dalle briglie di un progetto. Come il margine di Clément: sterpaglie indecise e prive di funzione che non si conformano, che sconfinano, che fanno la rivoluzione ecologica. Mi torna in mente la risposta di uno dei ragazzi che abbiamo fermato: il margine è una possibilità, uno spazio tra quello che è e quello che potrebbe essere.
Il margine è uno spazio che non esprime né potere né sottomissione al potere. Ed è questa la sua forza. Per dirla ancora con Clément, serve allontanarsi dagli spazi sottomessi alle norme per schierare i sentimenti della libertà. Non è da Helsinki o Londra che verrà il cambiamento. Nulla può discostarsi da un’egemonia culturale così forte ed efficiente, che ci avrà obbedienti, ordinati, consenzienti. Sono le periferie, le fabbriche, le ex colonie, le città sporche e disastrate gli spazi del futuro. Nonostante il margine sia stato caratterizzato per anni da una narrazione monolitica di degrado e mancanza di speranza, è solo lì che si può trasgredire. È una parola che mi piace, trasgressione. Viene intesa come mera infrazione delle regole, ma no, i trasgressori sono coloro che scoprono, riconoscono, rivelano i confini e li oltrepassano mostrando che c’è qualcosa al di là.
Mostrare che c’è qualcosa al di là. L’altro, gli altri. Gli scomodi, gli incontrollabili, i disordinati. Che non devono più essere nascosti – ognuno a casa sua, in privato – ma alla luce del sole, osceni più che mai. Anche la parola osceno mi sta a cuore – letteralmente significa presagio infausto, malaugurio. E che allora il margine sia un presagio di malaugurio per un centro che lo soffoca, lo relega ai bordi e tenta di annullarlo. Che il margine diventi un monumento all’inadeguatezza, un manifesto della diversità, che porti con fierezza il suo marchio. La vita non regolata secondo dogmi prestabiliti è un’occasione, una possibilità, la materializzazione di ciò che potrebbe esistere, realizzarsi, avvenire. Clément li chiama gli spazi del futuro, per me sono anche gli spazi del necessario.
Allora attraversiamo il margine, facciamoci margine. Trasgrediamo, sconfiniamo, facciamo un passo nell’ignoto e abitiamolo, comprendiamolo. Ascoltiamo la voce del confine, portiamola con noi. Seminiamola in pieno centro e lasciamola crescere, come le piccole piantine ostinate che nascono tra i sampietrini delle capitali.

Valentina Tamborra presenta, in anteprima assoluta, il suo ultimo libro, “Incontri al confine”, alla Libreria Verso di Milano. Appuntamento alle ore 19.00 in Corso di Porta Ticinese, 40. Dialoga con

Nel 1970 Curtis Mayfield incide un disco che segnerà profondamente la storia della musica afroamericana. Lo intitola semplicemente con il proprio nome: Curtis. Tra i brani in scaletta c’è anche Miss Black America, un affascinante gioco di specchi tra l’esaltazione della bellezza nera e una metafora del percorso che gli Stati Uniti dovranno ancora compiere per mettersi alle spalle secoli di razzismo e ingiustizie. Sappiamo bene che i cambiamenti si riveleranno più lenti e controversi del previsto, tuttavia ha senso partire proprio da questa canzone per provare a raccontare un’altra storia.

Il romanzo Frammenti di vetro (in lettone Stikli) si svolge in Lettonia tra il 1937 e il 1939, all’epoca della dittatura di Kārlis Ulmanis (1877-1942). Tutti i personaggi principali di questo libro, le cui voci si intrecciano toccando diversi piani temporali, sono però segnati, in maniera spesso dolorosa e traumatica.
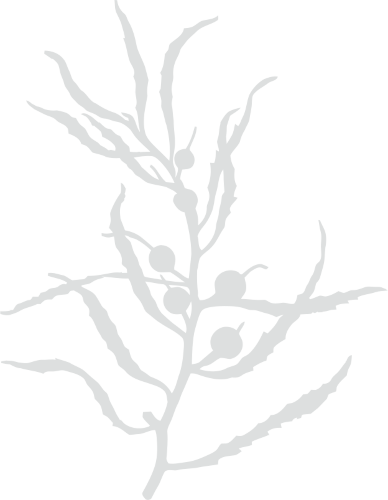
Mar dei Sargassi Edizioni
Via Armando Diaz 2
80055 Portici – Napoli
info@mardeisargassiedizioni.com
P.IVA 09826791213