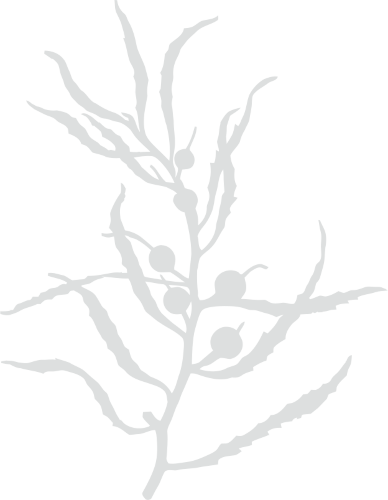Per tutta la vita mi sono sentita sbagliata perché il mio corpo non è conforme agli standard della società. Da quando ne ho memoria, il mio peso è stato un problema, qualcosa di cui vergognarsi, quasi un disonore.
Con il cibo ho sempre avuto un rapporto strano, inquieto. Per molti anni della mia vita ho mangiato soltanto pasta asciutta e biberon pieni di succo di frutta alla pera. Poi, a poco a poco, sono arrivate le cotolette, le fritture e sempre meno verdure. Da bambina mangiavo solo perché dovevo, non provavo piacere nel farlo. Il piacere è arrivato dopo, quando ho preso coscienza del mondo che mi circondava e non me ne sentivo parte integrante. Così, ho iniziato a sentirmi vuota e, lentamente, quella voragine ha tentato di inghiottirmi.
Prima l’apatia, poi la dipendenza affettiva. Della mia infanzia ricordo poco se non i miei genitori che si ammazzavano di lavoro, un’ossessione perenne per l’attività fisica, le diete ferree e l’odore dell’acido, il puzzo di vomito che usciva dal bagno ogni volta che ci entrava mia sorella appena adolescente e io che mi stranivo ma non capivo, non fino in fondo. Forse lo spettro del DCA si è insinuato in me in quei momenti, mentre aspettavo dietro la porta che mia sorella vomitasse anche l’anima per quel corpo che la faceva sentire in gabbia, proprio come il mio. E allora negli anni abbiamo trovato escamotage differenti per la nostra sofferenza. Lei le dita in gola e io il cibo, tanto cibo, montagne intere di cibo che finivano nel mio stomaco per tentare di colmare il vuoto che avevo dentro.
Sono passata in poco tempo dal provare la più totale apatia nei confronti del cibo all’amarlo alla follia, a far ruotare la mia intera esistenza attorno a esso. Perché il cibo era diventato il mio unico compagno fedele, l’unico sempre presente, che mi capiva e che mai mi avrebbe abbandonata o tradita. È così che ho iniziato a mangiare. Avevo fame d’amore, fame d’affetto, fame di vita… fame.
Della mia infanzia e, ancora di più della mia adolescenza, ricordo le diete fai da te, le privazioni, i cliché. Ricordo i pianti quando andavo a comprare dei vestiti nuovi perché gli abiti che mi piacevano non mi stavano bene ed ero costretta a comprarne di sformati, larghissimi, in modo tale che potessero nascondere la mia massa. Mai una gonna, solo pantaloni e magliette larghe perché non potevo permettermi di indossare altro. Ricordo gli sguardi sconcertati e quel senso di vuoto e di fame che cresceva.
Tornavo a casa esausta, sfinita, odiavo i compagni che mi invitavano alle loro feste di compleanno perché mi costringevano a ripetere quel tran-tran all’infinito. Per anni non sono andata più a fare shopping e, per almeno un paio, ho evitato di andare al mare. E poi la vita. Proprio quando cominciavo a trovare un equilibrio, ecco che la vita ha iniziato a picchiare forte, forse troppo per quel che ero capace di reggere e sopportare in quel momento. I miei si separano, qualche anno dopo arriva la malattia di mia sorella e poi la morte improvvisa di mio padre. E io ho solo fame, anche adesso mentre scrivo queste parole.
Convivo con il binge eating da tempo. A volte va meglio, altre peggio. Le ricadute non sono facili, anche perché come fai a spiegare il fatto che non sei mai sazia a qualcuno che non ha la tua stessa fame? Vari anni, mental breakdown e fasi depressive dopo, mi ritrovo a scrivere queste parole perché ventiduenne ho fatto pace con il mio corpo. Ho fatto pace con il mio essere in sovrappeso e con l’idea che sono molto di più che le mie cosce che sfregano, i miei fianchi larghi o il mio seno abbondante.
E io mi chiedo come si possa spiegare a qualcuno che di DCA non ha mai sofferto e che afferma che basta solo un po’ di sport per eliminare queste devianze giovanili quanto sia difficile vivere in un mondo che ti è così ostile. Quanto sia difficile dover comprare gli abiti online perché i negozi fisici espongono le taglie solo fino alla M. Quanto sia difficile vivere in armonia con il proprio corpo e la propria mente.
Come si fa a raccontare alla Meloni delle notti insonni trascorse a piangere perché troppo diversa. Della dipendenza affettiva, delle sedute dallo psicoterapeuta, delle sessioni di sport estremo pur di perdere quei chili in più per sentirmi un po’ più normale. Delle cene con gli amici evitate perché non mi sento a mio agio a mangiare in compagnia degli altri. Ma, soprattutto, come si fa a spiegarle che non si tratta di devianze ma di patologie, e di DCA, in quanto tali, non si può scegliere se soffrirne o meno.
I disturbi del comportamento alimentare sono infimi perché provocano ripercussioni non solo fisiche ma soprattutto mentali, danneggiando su più fronti chi ne soffre. Coloro che soffrono di DCA sviluppano problemi relazionali, emotivi e nello svolgimento delle normali attività sociali e lavorative, per non parlare delle varie complicazioni mediche.
Scrivo queste parole perché non tollero che nel 2022 si faccia una pessima propaganda elettorale sul mio corpo e su quello di centinaia e migliaia di persone che leggendo le mie parole si sentiranno comprese. La mia storia è anche quella dei tre milioni di italiani che soffrono di DCA. È estremamente svilente constatare che ancora oggi ci sia così tanta disinformazione.
Da una parte è un bene che si stia finalmente ponendo attenzione mediatica su questo problema sociale. Dall’altra, però, l’attenzione fine a se stessa è deleteria. Se si vuol parlare di qualcosa che non si conosce o che si conosce solo per sentito dire, la giusta informazione è d’obbligo. Per cui no, cara candidata Premier Meloni, non basta un po’ di sport per eliminare queste devianze giovanili che devianze non sono.
È giusto parlare di DCA, di disturbi del comportamento alimentare, facciamolo, confrontiamoci, puntiamo i riflettori su questo problema per anni finito nell’oblio pur essendo ancora così tristemente attuale. Però, facciamolo bene. Informandoci e informando, utilizzando i giusti termini, educando oltre che alla corretta alimentazione, all’accettazione personale, eliminando gli stereotipi di perfezione per cui magro è uguale a bello e sano e grasso è uguale a brutto e malato. Promuoviamo la psicoterapia che fa miracoli e che salva vite.
contributo a cura di Mariaconsuelo Tiralongo